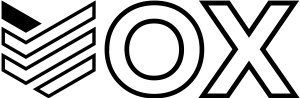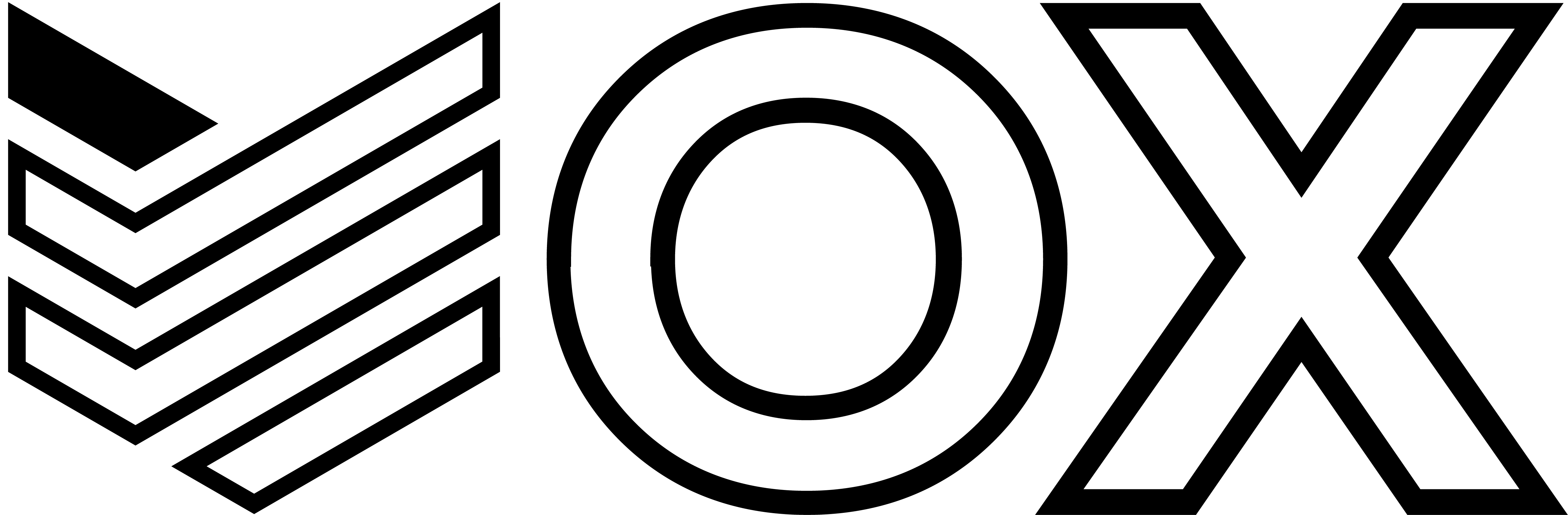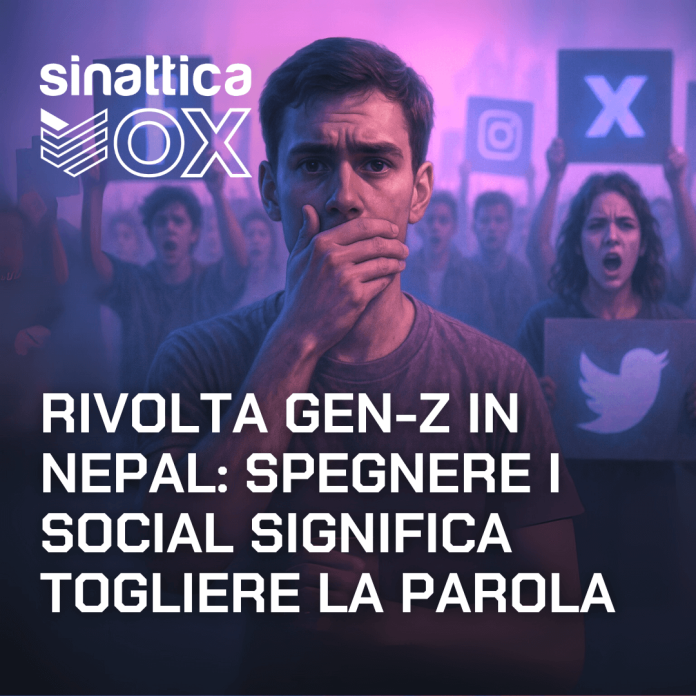In questo mese di settembre 2025 il governo del Nepal ha ordinato il blocco di 26 piattaforme social e di messaggistica — da Facebook e Instagram a WhatsApp, X e YouTube — scatenando proteste di massa guidate soprattutto dalla Generazione Z. Quella che è apparsa come una mossa tecnica per «far rispettare la normativa» si è trasformata presto in un termometro della politica: togliere l’accesso ai social network ha significato togliere spazi di identità, confronto e organizzazione. I giovani hanno risposto portando in piazza la loro rabbia; la repressione ha avuto costi umani drammatici e ha posto una domanda cruciale: chi decide oggi quali spazi del dibattito pubblico sono aperti e quali no?

Il blocco: atto tecnico o censura di fatto?
Secondo le autorità nepalesi, la misura sarebbe scattata perché molte piattaforme non si erano adeguate a nuovi requisiti di registrazione e responsabilità locale. Nella pratica, però, l’ordine di oscurare applicazioni diffuse su scala nazionale ha sospeso l’unico canale quotidiano di informazione e relazione per milioni di persone, riducendo drammaticamente la possibilità di esprimersi, coordinarsi o perfino lavorare. La decisione ha rivelato quanto i governi contemporanei percepiscano i social non solo come media ma come leve di potere: controlli di accesso sono strumenti politici, non meri meccanismi tecnici.
La conseguenza immediata è stata la mobilitazione: giovani che non si riconoscono nella classe politica, che vedono dilagare corruzione e nepotismo, hanno trovato nei social la possibilità di raccontare, indignarsi e invocare cambiamento. Quando quella piazza digitale è stata chiusa, la piazza fisica è esplosa. I cortei hanno mostrato che la distanza tra intrattenimento e politica per la Gen-Z semplicemente non esiste più: meme, video e le dirette sono diventati strumenti di azione civica.
I numeri della crisi e la risposta internazionale
Le proteste sono state dure, con denunce di uso eccessivo della forza. Fonti internazionali riferiscono decine di vittime e migliaia di feriti, eventi che hanno costretto a indagini e a cambi di governo. Allo stesso tempo, le piattaforme e le organizzazioni per i diritti digitali hanno denunciato la misura come una violazione della libertà di espressione e del diritto all’informazione. Questi sviluppi non sono un fatto isolato: l’abitudine di limitare l’accesso alla Rete in momenti di crisi è una tendenza globale che l’ONU e le ONG per i diritti digitali hanno più volte condannato perché impatta su una serie di diritti fondamentali (lavoro, istruzione, salute, partecipazione politica).
Perché i social network sono diventati “piazze pubbliche” digitali
Nel corso degli ultimi quindici anni i social hanno progressivamente assunto funzioni tipiche degli spazi pubblici: consentono accesso all’informazione, facilitano l’espressione collettiva, abilitano pratiche di watchdogging e creano micro-comunità attive. Per molti giovani – specialmente nelle società dove i media tradizionali sono politicizzati o poco accessibili – i social sono l’unico punto di contatto con il resto del mondo e il luogo dove esercitare diritti civili e politici. Gli eventi nepalesi sottolineano che limitare questi spazi equivale a ridurre la sfera pubblica stessa.
Non è un caso che le corti e le istituzioni democratiche di molti paesi stiano cominciando a riconoscere i social come spazi essenziali del dibattito politico: se la cittadinanza si esercita anche online, allora la regolazione dell’accesso e la governance dei dati diventano questioni di democrazia. Chi decide chi parla, cosa si può dire e come? E secondo quali regole? Queste domande si collocano oggi al centro del dibattito sulla governance digitale.
Il ruolo (e i limiti) degli operatori privacy e dei professionisti dei dati
I professionisti della privacy non possono limitarsi a interpretare testi normativi o a raccogliere consensi in modo passivo. Quando uno Stato chiude un canale, i Data Protection Officer (DPO), i garanti e i consulenti privacy si trovano a dover difendere non solo la conformità tecnica, ma i diritti fondamentali collegati ai trattamenti digitali. Devono esercitare vigilanza sul rapporto tra piattaforme private e utenti, rivendicare trasparenza negli algoritmi di moderazione, e segnalare abusi che assomiglino a censura.
Questo non vuol dire sostituirsi al decisore politico, ma significa che la comunità professionale ha un ruolo attivo di «guardiano»: verificare che i blocchi siano proporzionati, temporanei, legalmente fondati e non discriminatori; accertare che i dati raccolti da governi o piattaforme non vengano impiegati per sopprimere il dissenso; promuovere soluzioni tecniche che mantengano la possibilità di comunicare anche in condizioni di blocco selettivo (es. mesh networks, mirror sites, protocolli alternativi). In breve: proteggere la privacy è anche proteggere lo spazio pubblico.
Libertà di espressione vs. responsabilità delle piattaforme
Il caso Nepal mette in luce una tensione politica e tecnica: le piattaforme, controllate da grandi operatori privati, applicano regole e decidono i flussi di visibilità. I governi chiedono responsabilità, spesso imponendo registrazioni locali, rappresentanti legali o filtri; le big tech rivendicano autonomia operativa e principi di governance globale. Nel mezzo ci stanno le persone: se i provider cedono troppo potere agli Stati, o se invece rifiutano completamente ogni regolazione, il risultato rischia sempre di ridurre lo spazio di parola reale. Serve un equilibrio che salvaguardi libertà e sicurezza.
La dimensione culturale: la Gen-Z ridefinisce la piazza pubblica
La ribellione Nepalese è un segnale generazionale. I nati con gli smartphone vedono i confini tra intrattenimento, attivismo e partecipazione politica come inesistenti. Un meme può diventare una protesta, un commento può mobilitare, una diretta può documentare violazioni di potere. Per loro, chiudere Instagram non significa solo perdere contenuti: significa perdere rappresentanza, identità e memoria collettiva. I decisori che ignorano questo rischio subiscono una reazione proporzionale alla portata simbolica del gesto.
Un avvertimento e una speranza
Spegnere i social può apparire come una soluzione rapida per contenere crisi o disinformazione. Ma la storia recente — dal Nepal al Myanmar, dall’Iran allo Sri Lanka — mostra che la chiusura dell’accesso alla Rete non spegne la protesta: la può acutizzare, delegittimare lo Stato e generare costi economici e umani devastanti. Allo stesso tempo, la rivolta della Gen-Z indica che il senso civico digitale è vivo: i giovani non si limitano a consumare contenuti, li producono e li usano per chiedere giustizia. È un punto di forza da proteggere, non un rischio da arginare con il pugno di ferro.